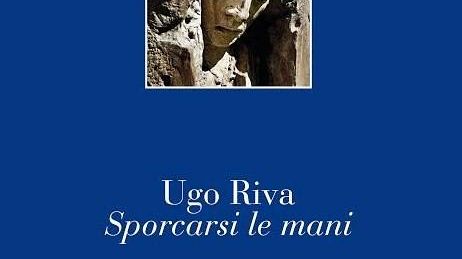FIRENZE - Nell’era sciagurata del qualunquismo e dei tuttologi, dove ogni occasione è buona per parlare d’arte, più o meno a proposito, la presentazione di un libro d’artista può perdersi nell’abituale caos di parole e immagini. Tuttavia sorprende piacevolmente l’imbattersi in avventure editoriali intellettualmente oneste, che con tono sommesso e lontano dai riflettori, si offrono ai lettori come racconti in forma di conversazione, e mettono a nudo l’anima vera di un artista. Accade con Sporcarsi le mani, volume scritto Ugo Riva in collaborazione con il critico Flavio Arensi, appena pubblicato per i tipi di FMR e presentato nei rinascimentali spazi dell’Atelier Tommasi, che Riva ha scelto quale sede fiorentina d’elezione.
Lo spunto per il volume è nato da una lunga intervista a suo tempo concessa ad Arensi da Riva, in seguito ampliata fino a diventare una piccola biografia che unisce la realtà dell’arte ad aneddoti di vita vissuta. In queste pagine, lo scultore racconta l’essenza del suo agire, che si riassume proprio nel titolo; stiamo infatti attraversando un’epoca, anche nell’arte, in cui il coinvolgimento diretto nell’azione e nei concetti è sempre meno diffuso, in particolare a causa della tecnologia, che aliena gli individui dal contatto con la realtà. Nello specifico, gli scultori contemporanei hanno poca familiarità con il loro stesso mestiere, spesso ricorrendo all’aiuto di esperti artigiani che realizzano i loro bozzetti, oppure servendosi di strumenti tecnologici all’avanguardia. Fedele alla vecchia scuola, Riva preferisce toccare con mano i materiali che utilizza, addomesticarli secondo il proprio volere, imponendo loro una ben precisa forma, frutto dell’ingegno personale.
La ricerca di Ugo Riva comincia da materiali “primitivi” quali bronzo e terracotta, materiali che hanno accompagnato il cammino evolutivo dell’uomo, che gli hanno permesso di affinare lo spirito d’osservazione, la manualità, il senso di appartenenza a una realtà composita, e la consapevolezza di poter modellare questa stessa realtà. Un sottile senso onirico si aggiunge a questo approccio di stampa vagamente illuminista, come se l’artista scolpisse in poesia anziché in prosa, lasciandosi coinvolgere sin nella sua più piccola cellula del corpo.
È interessante seguire Riva nella sua parabola artistica, raccontata con l’onestà di ci ha sempre creduto nel proprio lavoro. Nasce pittore, per approdare all’informale, strada battuta però con scarsa convinzione, nel dubbio di stare facendo qualcosa di banale. La svolta, nell’incontro con l’opera di Piero della Francesca, ovvero nell’attenta osservazione delle sue maternità celesti. Per Riva si trattò di una rivelazione artistica, che lo spinge a tornare alla figurazione, ma sottoforma di sculture.
Le sue Maternità furono lodate da Mario De Micheli (l’ultimo grande critico della scultura in Italia), che lo ha incoraggiato a proseguire sulla strada intrapresa. A distanza di anni, Riva ammette come il difficile, nella scultura, sia estrapolare l’anima, che di per sé è concetto impalpabile, mentre il bronzo, la terracotta, il marmo, sono materiali pesanti, particolarmente corporei. Eppure, il “miracolo” avviene, se ci si avvicina all’arte con il dovuto rispetto, con quell’umiltà che ti porta a sfidare la massa informe che ti sta davanti, e modellarla fino a liberarne la figura desiderata.
Ugo Riva racconta di sé questo e molto altro del suo lavoro, insistendo però sulla necessità di un ritorno all’arte “vera”, quella, cioè, perseguita sentendo dentro il fuoco di un ideale, e realizzata attraverso la manualità.
Ma la scultura è oggi un’arte purtroppo ai margini di un mercato artistico che indulge verso il sensazionale, la provocazione e l’immediatezza. Quando invece la scultura richiede tempo, pazienza, riflessione, concetti che sembrano appartenere a un’altra epoca. Concetti profondamente umani, però, con i quali sarebbe opportuno riprendere familiarità. Ma per farlo, occorre ripensare il rapporto fra l’arte e il pubblico dei meno esperti, e il libro di Riva e Arensi è anche occasione per dialogare sulla profonda crisi culturale che stiamo attraversando, del solco sempre più ampio tracciato fra l’artista e i “comuni mortali”.
Secondo il critico Arensi, è necessario che anche il pubblico si “sporchi le mani”, ovvero che riprenda il contatto con l’arte, con il bello, che provi per esso curiosità e ne faccia oggetto di ragionamento. La crisi dell’arte italiana è dovuta alla perdita della cultura del bello, come purtroppo ben spiegano i tanti orrori architettonici che deturpano interi quartieri urbani, o il cattivo gusto di tanti monumenti che rendono le piazze cittadine luoghi anonimi abbandonati al degrado.
L’importanza del bello nell’arte pubblica è testimoniato dalle sculture di Jean-Baptiste Carpeaux e Emile Antoine Bourdelle, realizzate rispettivamente per l’Opera Garnier e il Teatro degli Champs Elysées a Parigi, tra la fine dell’Ottocento e il primo Novecento. Carpeaux realizzò una serie di nudi femminili, lontani però dalla bellezza classica, e vicini alla bellezza reale delle donne, ovvero punteggiate qua e là di piccoli difetti che all’occhio della censura dell’epoca passarono per oscenità. Napoleone III avrebbe voluto demolire le statue, ma la sconfitta di Sedan non gliene lasciò il tempo.
Trent’anni più tardi, Bourdelle immortalò Isadora Duncan e Vaslav Nijinsky che ballano di profilo nell’Aprés-midi d’un faune, spettacolo di punta dei Ballets Russes. Opere che i francesi hanno visto quotidianamente nel loro muoversi per la città, che li hanno abituati a confrontarsi con una bellezza reale, non perfetta, ma fiera di sé stessa e capace di osare. In tal modo, l’arte pubblica diviene strumento di educazione al bello, a differenza dei quadri, chiusi nei musei o nelle dimore dei privati collezionisti.
Invece, l’arte a cielo aperto è visibile a tutti, gratuitamente, ed è strumento quotidiano per quell’arte civile che sa parlare alla gente comune. In Italia, nell’ultimo mezzo secolo si è purtroppo persa la cultura del bello, in particolare a livello pubblico, e mancando un’educazione dal basso, e una conseguente spinta all’osservazione, è arduo per gli artisti parlare direttamente all’uomo comune. Non aiutano i tanti filtri interpretativi che appesantiscono le mostre, anche le più belle, quali gli apparati didattici dell’allestimento, e i testi critici dei cataloghi. Fondamentale sarebbe, lasciar parlare le opere d’arte, permettendo al pubblico di ammirarle in silenzio, senza quel caos di parole che le accompagna d’abitudine.
Si avverte il bisogno di un ritorno all’arte autentica, alla sua essenza di colori, forme e concetti, sia da parte degli artisti, sia da parte di chi osserva. L’appello a sporcarsi le mani vale anche in questo senso.